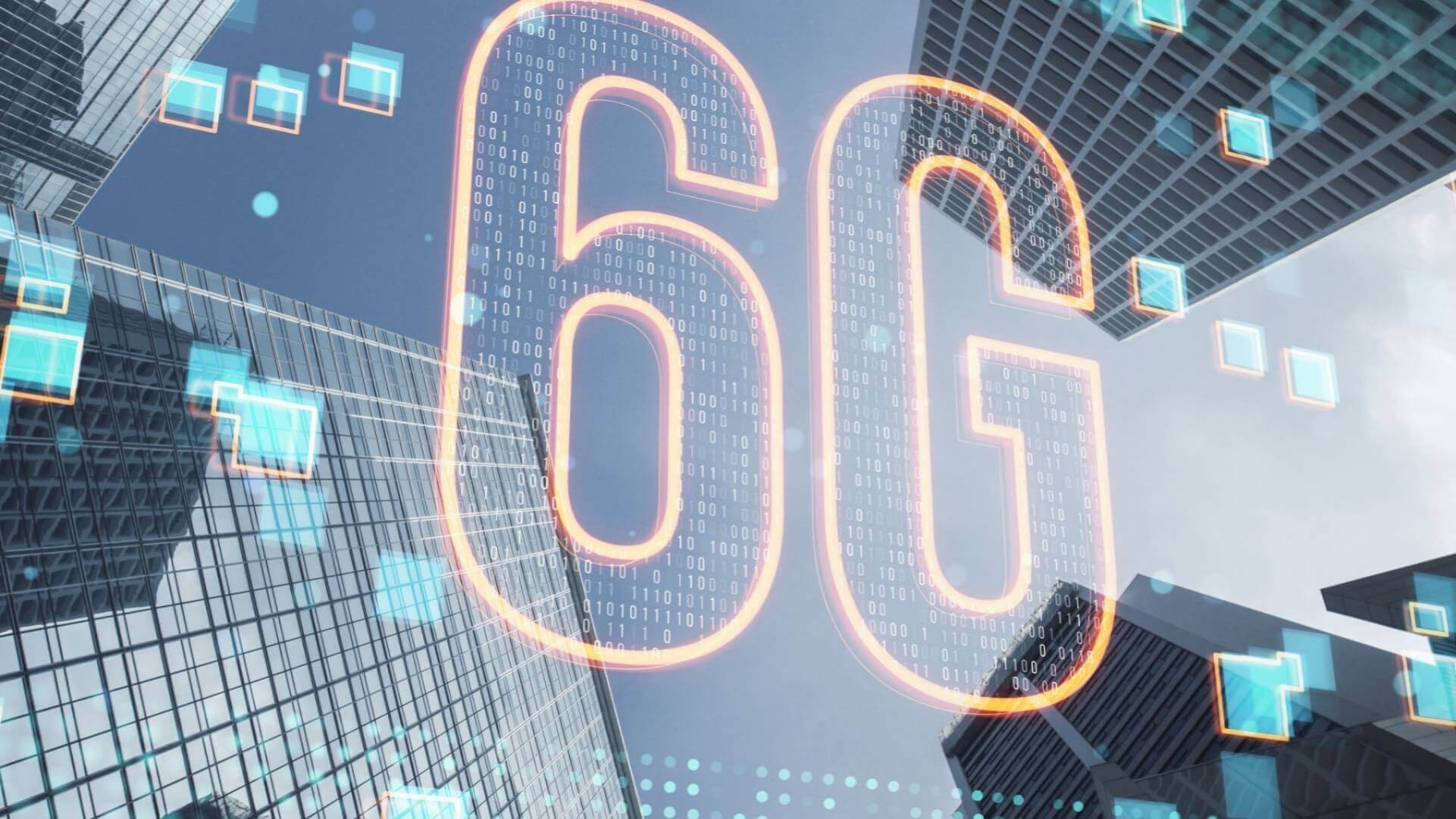Nel percorso che conduce alla prossima generazione di connettività, la ricerca e sviluppo 6G non si misura soltanto con i limiti tecnologici, ma con la capacità di creare ecosistemi aperti e sostenibili. Lo ha sottolineato Alessandro Pane, Direttore R&D di Ericsson Italia, in occasione di un incontro con la stampa dedicato ai progetti dei centri di ricerca italiani dell’azienda. Il tema di fondo è la trasformazione della ricerca industriale in una rete programmabile di idee, competenze e collaborazioni, in cui l’obiettivo non è più soltanto inventare nuove soluzioni, ma imparare a riprogrammare l’innovazione stessa.
Indice degli argomenti
Dalla rete al laboratorio: l’R&D come ecosistema
Negli ultimi quarant’anni, Alessandro Pane ha attraversato tutte le generazioni mobili, dall’analogico al digitale. La sua visione di lungo periodo aiuta a capire come la ricerca e sviluppo 6G stia assumendo una forma diversa rispetto al passato. «Il nostro mantra è sviluppare, creare, avere passione, ma soprattutto innovare», spiega. Innovare, però, non significa soltanto sperimentare tecnologie, bensì costruire un modello culturale che renda l’innovazione parte del DNA aziendale.
In Italia, le sedi Ericsson di Genova, Pisa e Pagani operano come poli complementari. Genova si occupa di ottica e fotonica applicate alla radio e al trasporto; Pisa è dedicata alla ricerca fotonica e ai sistemi di management; Pagani ospita il centro per le soluzioni regolatorie e di sicurezza delle reti. Quest’ultimo è l’unico al mondo nel gruppo dell’azienda a sviluppare software per le intercettazioni legali, componente oggi indispensabile per la gestione sicura delle comunicazioni.
A fianco delle attività core, Pane cita oltre un centinaio di collaborazioni attive con università, centri di ricerca e imprese. «Ogni anno si rinnovano, ma non sono mai meno di cento», osserva, sottolineando come i progetti spingano sull’interazione tra accademia, impresa e innovazione pubblica. Parte dei fondi proviene da programmi europei come Horizon 2020 e da iniziative nazionali gestite dai ministeri dello Sviluppo Economico e della Ricerca. Questo modello ha permesso alla divisione italiana di superare i mille brevetti registrati dal 2000, con una media annuale di 60–80 nuove invenzioni e un crescente coinvolgimento di giovani ricercatori.
Le reti programmabili e il salto verso il 6G
Se il 5G ha reso possibile la comunicazione intelligente, il 6G promette di rendere intelligente la rete stessa. Il tema centrale dei lavori di quest’anno è quello delle Programmable e Self-Programmable Network, reti capaci di adattarsi alle esigenze del momento. «Vogliamo reti che si configurano da sole in base al servizio», afferma Pane, descrivendo uno scenario in cui la connettività si regola autonomamente per gestire picchi di traffico o priorità di missione.
L’Italia, secondo Pane, non ha ancora espresso tutte le potenzialità del 5G, perché la sua infrastruttura è ancora “ibrida” tra apparati di nuova generazione e componenti più datate. Tuttavia, la transizione è in corso e costituisce il punto di partenza per la ricerca e sviluppo 6G, prevista per entrare in una fase pre-industriale entro il 2030.
La visione tecnologica di Pane include la convergenza tra rete terrestre e satellitare, l’integrazione del machine learning nella gestione delle connessioni e la progressiva ibridazione con i quantum computer, che permetteranno un’elaborazione più rapida dei dati. «L’intelligenza artificiale entra pesantemente nelle nostre tematiche», spiega, ma non come moda lessicale: l’AI è vista come motore di automazione e di resilienza della rete, oltre che di efficienza energetica.
Dati, fiducia e resilienza delle infrastrutture
Nell’ecosistema digitale che si va delineando, la sicurezza non è più un modulo accessorio ma un asse strategico della ricerca e sviluppo 6G. Pane descrive la costruzione di sistemi “full trust”, capaci di reagire in tempo reale a minacce cibernetiche. «Gli attacchi alle reti sono quotidiani, parliamo di centinaia di milioni di eventi internazionali», afferma. L’AI viene impiegata per effettuare uno scouting continuo delle vulnerabilità, riconoscere i “talloni d’Achille” e generare contromisure dinamiche.
Le dimostrazioni di quest’anno hanno mostrato reti in grado di simulare e respingere intrusioni, proteggendo nodi critici come auto connesse, ambulanze e sale operatorie remote. La logica è la stessa che guida la transizione verso le “cognitive networks”: sistemi che imparano a riconfigurarsi da soli, mantenendo continuità di servizio anche in presenza di stress operativi o picchi di domanda. È un’idea di resilienza che supera il perimetro tecnico per diventare filosofia progettuale.
La sperimentazione come metodo
Nel racconto di Pane, l’innovazione non è un prodotto finito ma un processo di validazione continua. L’esempio delle 15 demo realizzate nel 2025 mostra un approccio sperimentale esteso a settori diversi, dal gaming alla gestione urbana. In una delle dimostrazioni, la connettività veniva adattata automaticamente per evitare congestioni durante grandi eventi sportivi. In un’altra, sensori installati sui contenitori dei rifiuti consentivano di ottimizzare i percorsi di raccolta in base al riempimento effettivo, riducendo tempi e consumi di CO₂.
Tra i progetti più significativi figura lo sviluppo di tecnologie di transizione tra rete terrestre e satellitare, che permettono comunicazioni continue anche in mare aperto, senza la necessità di dispositivi satellitari dedicati. «Abbiamo realizzato una comunicazione senza interruzione tra la rete 5G e il satellite, utilizzando lo stesso telefono», racconta Pane, descrivendo il test su una nave equipaggiata con sistemi adattivi di connettività.
Innovazione sociale e trasferimento tecnologico
Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Ericsson Italia riguarda la ricerca applicata in ambito sociale e sanitario. Pane cita diversi esempi, tra cui la collaborazione con l’organizzazione no-profit DLAB in Uganda per digitalizzare una culla destinata a monitorare i parametri vitali dei neonati in aree rurali. «Abbiamo creato un prototipo che invia in tempo reale temperatura e respirazione a un medico in centrale», spiega, evidenziando il potenziale di queste soluzioni per la prevenzione epidemica e il supporto alle madri lavoratrici.
Un altro progetto, sviluppato con l’Istituto Italiano di Tecnologia, riguarda una mano robotica connessa via 5G, in grado di riconoscere e afferrare oggetti attraverso impulsi elettrici tradotti dalla rete. «La rete permette alla mano di adattarsi e cambiare comportamento, come fosse un arto naturale», osserva Pane. L’idea è che la rete programmabile diventi estensione sensoriale e cognitiva degli oggetti, non solo canale di trasmissione.
Infine, la collaborazione con Burelli Group ha portato alla creazione di un sistema di ambulanza connessa, capace di inviare elettrocardiogrammi in tempo reale a un centro di controllo. Un algoritmo di intelligenza artificiale analizza i tracciati e suggerisce una seconda diagnosi di supporto al medico. «Il dottore decide sempre, ma può confrontare l’ECG reale con quello suggerito dal sistema AI», precisa Pane, spiegando come questa doppia visione migliori la precisione del triage.
Il futuro della connettività
Guardando oltre il 6G, Pane immagina un’evoluzione che cambia il rapporto con i dispositivi. «Il telefono sarà un oggetto strano da portare», afferma. «Indosseremo occhiali connessi che ci permetteranno di comunicare, vedere mappe o ricevere informazioni in tempo reale». Una visione che non appartiene al marketing del futuro, ma alla logica di un’innovazione che nasce nei laboratori di ricerca e sviluppo 6G e si traduce in una quotidianità più intelligente, flessibile e umana.