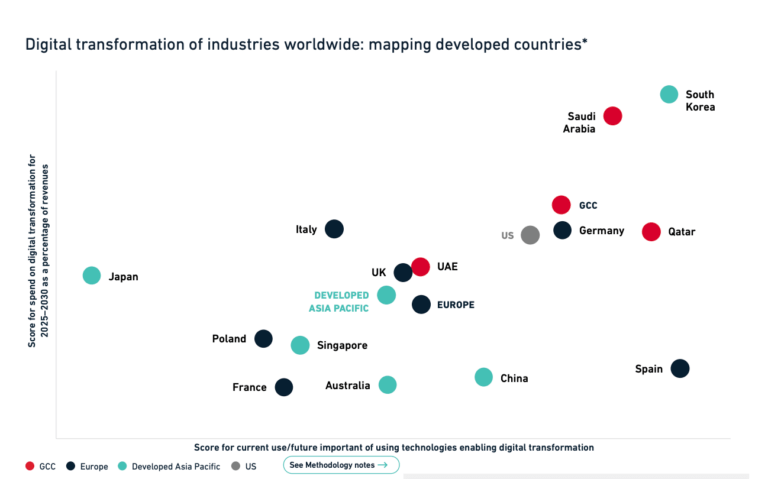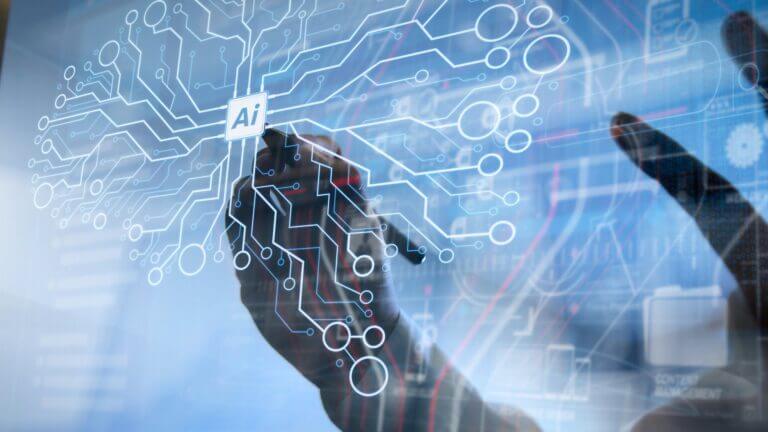La trasformazione delle critical communications è in pieno corso. Per decenni, le comunicazioni mission-critical si sono affidate alla tecnologia Land Mobile Radio (Lmr), che pur essendo robusta, presentava limiti evidenti in termini di banda, interoperabilità e capacità di trasmissione dati. Oggi, grazie all’evoluzione delle reti cellulari Lte e 5G, il settore sta vivendo una rivoluzione. Le nuove reti offrono velocità, affidabilità e possibilità di segmentazione tramite slicing, permettendo la creazione di reti private dedicate con parametri di qualità del servizio specifici.
Secondo il white paper pubblicato da Mobile World Live in partnership con nVent Schroff, il mercato globale delle comunicazioni mission-critical su reti cellulari è destinato a raggiungere i 21,7 miliardi di dollari entro il 2032. La crescita è trainata dalla necessità di garantire connettività sicura e continua per settori come sanità, difesa, energia, finanza e servizi di emergenza. La sfida per gli operatori mobili e i produttori di infrastrutture è duplice: da un lato devono assicurare la sicurezza software, dall’altro devono investire in soluzioni hardware capaci di resistere a condizioni estreme e garantire operatività costante.
Indice degli argomenti
Cabinet evoluti e protezione ambientale
La sicurezza fisica delle infrastrutture è il primo tassello per garantire la resilienza delle reti mission-critical. I cabinet che ospitano router, switch, alimentatori e componenti di rete devono essere progettati per resistere a eventi climatici estremi, atti vandalici, sabotaggi e guasti elettrici. Le soluzioni più avanzate utilizzano materiali anticorrosione, sistemi di chiusura multipunto, rilevatori di intrusione e controllo elettronico degli accessi.
La protezione non si limita alla struttura meccanica. I cabinet devono offrire schermatura elettromagnetica per evitare interferenze da frequenze esterne e devono essere conformi agli standard sismici internazionali, come l’Iec 61587. Anche la protezione contro polveri, acqua e temperature estreme è fondamentale, e viene misurata tramite gli Ingress Protection Rating. Questi parametri indicano il livello di protezione ambientale e la durata operativa prevista dei dispositivi contenuti.
Gestione termica e continuità operativa
L’aumento della velocità e della banda disponibile comporta un incremento significativo del calore generato dai dispositivi. La gestione termica diventa quindi cruciale per evitare guasti e ridurre il costo totale di proprietà. Le soluzioni proposte nel white paper includono sistemi di climatizzazione per ambienti industriali, tecnologie di raffreddamento a circuito aperto per ambienti controllati, scambiatori di calore a bassa manutenzione, riscaldatori per proteggere da freddo e condensa, sistemi termoelettrici basati sull’effetto Peltier e soluzioni a vortice che utilizzano aria compressa per raffreddare senza refrigeranti.
Queste tecnologie permettono di mantenere la temperatura ottimale anche in condizioni estreme, garantendo la continuità del servizio e la protezione dei componenti elettronici. Il controllo preciso della temperatura è essenziale per evitare variazioni di tensione, degrado dei materiali e riduzione della vita utile dei dispositivi.
Alimentazione resiliente e gestione intelligente dell’energia
La gestione dell’alimentazione è un altro pilastro della sicurezza. Le interruzioni di corrente, causate da eventi atmosferici o guasti, possono compromettere la funzionalità delle reti. Le soluzioni più avanzate prevedono unità di distribuzione dell’energia con monitoraggio remoto, prese bloccabili e rilevamento dello stato dei circuiti. In caso di blackout, entrano in gioco batterie e celle a combustibile a idrogeno, che offrono efficienza energetica, zero emissioni e lunga autonomia.
La transizione verso fonti rinnovabili ha portato all’adozione del Direct Current Distribution Unit (Dcdu), che gestisce la distribuzione dell’energia Dc, ottimizza i cicli di carica e scarica e abilita il monitoraggio predittivo. Questo approccio consente agli operatori di anticipare i guasti, migliorare la resilienza e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.
Applicazioni avanzate e casi d’uso globali
Le reti cellulari mission-critical sono già operative in diversi Paesi. Il progetto europeo BroadWay, guidato da Airbus, collega le forze di sicurezza di undici nazioni. In Germania, il programma D-Lbo ha l’obiettivo di digitalizzare le forze terrestri della Bundeswehr. Negli Stati Uniti, la rete FirstNet supportata da AT&T copre quasi tre milioni di miglia quadrate. In Francia, il progetto Rrf permetterà a 300.000 soccorritori di comunicare in tempo reale. Il Regno Unito ha avviato la rete Esn per garantire accesso immediato a dati vitali. In Corea del Sud, Safe-Net collega 333 agenzie di sicurezza con funzionalità push-to-talk e trasmissioni multimediali.
Questi progetti dimostrano come Lte e 5G stiano abilitando applicazioni avanzate, tra cui video in tempo reale, droni, analisi termiche, realtà aumentata e virtuale, e trasporti autonomi. La banda ultralarga è il fattore abilitante di queste innovazioni, come evidenziato nel pillar dedicato di CorCom.
Manutenzione proattiva e test continui
Anche le infrastrutture più avanzate devono essere sottoposte a test regolari. Gli operatori devono effettuare simulazioni ambientali, analisi dei guasti, aggiornamenti firmware e audit di sistema. Queste pratiche aumentano la durata dei componenti e riducono i costi da guasti. La manutenzione proattiva consente di identificare vulnerabilità, migliorare le prestazioni e garantire la sicurezza operativa.
Il white paper sottolinea l’importanza di adottare pratiche di installazione corrette, utilizzare componenti certificati, monitorare la temperatura e l’energia, e limitare l’accesso ai soli operatori autorizzati. La resilienza non è un obiettivo statico, ma un processo continuo che richiede attenzione, investimento e innovazione.