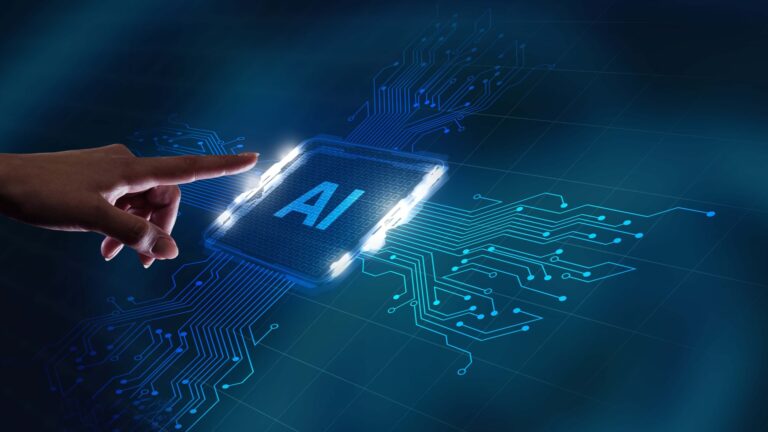Siamo di fronte a un cambiamento radicale nel panorama della sicurezza informatica. I modelli di intelligenza artificiale uncensored e “abliterated” (versioni modificate di AI open-source a cui sono state chirurgicamente rimosse tutte le barriere etiche) stanno trasformando quello che fino a ieri era un privilegio di pochi esperti in una capacità accessibile a chiunque disponga di un computer portatile. Questa democratizzazione della potenza offensiva rappresenta una discontinuità tecnologica che sfida ogni paradigma tradizionale di controllo, e le sue implicazioni per le infrastrutture di rete e i sistemi di comunicazione sono tanto profonde quanto sottovalutate. Il fenomeno opera in una zona d’ombra della consapevolezza collettiva.
l’analisi
Dark AI e modelli “abliterated”: sale il rischio cyber per le reti di Tlc
Sistemi di intelligenza artificiale “manipolati” ampliano la platea degli aggressori, facilitano attacchi complessi e impongono agli operatori di investire in difesa distribuita, architetture zero trust e nuove competenze
Cybersecurity Research Lead, Cefriel
Cybersecurity Research, Cefriel

Continua a leggere questo articolo
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business