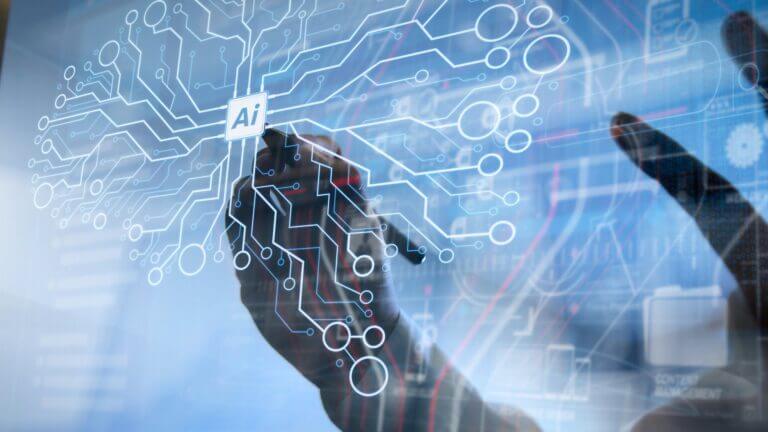Vola il settore dei data center in Italia. L’ultimo report di Ida (Italian Data Center Association) nei prossimi cinque anni prevede 21,8 miliardi di investimenti: il settore è pronto a trasformarsi in uno dei motori dell’economia nazionale, con una crescita del 40% fra 2024 e 2029.
L’Italia sta assumendo dunque un ruolo centrale come piattaforma europea per il cloud e l’intelligenza artificiale: è Milano vicina alla saturazione, crescono i poli del Sud. Importanti risvolti anche sul fronte lavorativo: i data center in colocation e hyperscale oggi impiegano circa 1.200 professionisti a tempo pieno, ma il numero è destinato ad avvicinarsi a 6.000 entro il 2029
Ma non mancano le sfide: dalla disponibilità di energia e di infrastrutture di rete, alla semplificazione dei processi autorizzativi, fino alla formazione di competenze adeguate.
Propriol’introduzione di un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di data center sarà centrale per accelerare lo sviluppo. Ne discutiamo con l’avvocata Carmen Chierchia, Partner DLA Piper.
L’introduzione di un procedimento unico per le autorizzazioni ai data center viene indicata come una misura chiave per accelerare gli investimenti. Quanto può incidere davvero sulla rapidità dei progetti e quali sono, a suo avviso, gli ostacoli normativi ancora da superare?
L’introduzione di un procedimento unico per le autorizzazioni ai data center rappresenta senza dubbio una misura strategica per accelerare gli investimenti in un settore sempre più centrale per la competitività del Paese. Una revisione dell’iter autorizzativo è infatti auspicata da tempo non solo per i data center, ma per tutte le asset class: serve una riforma organica che restituisca certezza sui tempi e sulle modalità procedurali, oggi spesso frammentate e disomogenee. Nel caso dei data center, tuttavia, l’esigenza di semplificazione è ancora più urgente. Si tratta di edifici complessi, che richiedono l’interazione tra molteplici discipline e competenze: urbanistica, edilizia, ambiente, paesaggio, sicurezza, energia, infrastrutture digitali. Questa pluralità di profili genera inevitabilmente sovrapposizioni e interferenze tra procedimenti, con il rischio di allungare i tempi e aumentare l’incertezza per gli operatori.
Cosa serve per assicurare un procedimento efficace?
Un procedimento unico ben strutturato potrebbe portare ordine e coerenza, ma per essere davvero efficace deve poggiare su una conoscenza approfondita di questa asset class da parte del legislatore. È necessario un quadro normativo chiaro, ma al tempo stesso flessibile, capace di adattarsi all’evoluzione tecnologica e alle specificità dei progetti. Accanto alla riforma normativa, è fondamentale investire nella formazione delle amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni. Solo attraverso una maggiore consapevolezza tecnica e giuridica sarà possibile valutare con equilibrio e competenza le caratteristiche dei progetti, garantendo al contempo la tutela dell’interesse pubblico e la promozione dell’innovazione.
L’Italia sta assumendo un ruolo centrale come piattaforma europea per il cloud e l’intelligenza artificiale. Quali condizioni servono, dal punto di vista legale e regolatorio, perché il nostro Paese diventi davvero competitivo e attrattivo per gli investitori internazionali?
Perché l’Italia diventi davvero competitiva come hub europeo per il cloud e l’intelligenza artificiale, è essenziale creare un quadro normativo stabile, trasparente e orientato all’innovazione. Servono procedure autorizzative snelle e coordinate, capaci di ridurre l’incertezza e i tempi decisionali. È fondamentale una governance chiara tra i diversi livelli istituzionali, oltre a una normativa che riconosca la specificità di queste infrastrutture strategiche, come i data center, e ne favorisca lo sviluppo con regole flessibili ma certe. Occorre inoltre investire nella formazione delle amministrazioni coinvolte, affinché possano valutare con competenza progetti ad alta complessità tecnologica. Infine, la competitività passa anche dalla certezza fiscale e dalla tutela degli investimenti: solo così l’Italia potrà attrarre operatori globali e consolidare il proprio ruolo nel panorama digitale europeo.
Lo sviluppo dei data center pone anche il tema della sostenibilità: consumi energetici, uso del territorio, impatto ambientale. In che modo la normativa può conciliare la semplificazione dei processi con il rispetto degli standard ambientali e di efficienza energetica?
È importante ricordare che, già oggi, le infrastrutture di una certa potenza sono sottoposte a rigorosi controlli ambientali. In molti casi, sono soggette a procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o a valutazioni ambientali vere e proprie, e devono rispettare parametri prestazionali elevati, anche in termini di efficienza energetica, consumo idrico, emissioni e impatto sul territorio. La normativa può e deve conciliare la semplificazione dei processi con il rispetto degli standard ambientali, ma per farlo è necessario un approccio consapevole e strutturato. Serve una regolazione che riconosca la specificità dei data center come asset strategici, introducendo un quadro autorizzativo chiaro, coordinato e proporzionato, che eviti duplicazioni e conflitti tra normative settoriali. Al tempo stesso, è fondamentale che le amministrazioni coinvolte siano formate e aggiornate, così da poter valutare con competenza e responsabilità i progetti, bilanciando le esigenze di tutela ambientale con quelle di sviluppo tecnologico. La sostenibilità non deve essere percepita come un ostacolo, ma come un elemento qualificante e competitivo per attrarre investimenti di lungo periodo.
Il piano da 21 miliardi nei prossimi cinque anni promette una crescita importante. Ma senza competenze adeguate il rischio è di rallentare. Che ruolo possono avere le imprese, le istituzioni e il diritto nel favorire la formazione e la diffusione delle competenze digitali necessarie?
Il piano da 21 miliardi rappresenta un’opportunità straordinaria, ma senza competenze adeguate rischia di rimanere inattuato. Le imprese possono giocare un ruolo chiave investendo nella formazione continua dei propri team e collaborando con università e centri di ricerca per sviluppare percorsi mirati alle nuove sfide digitali. Le istituzioni, dal canto loro, devono sostenere politiche pubbliche che incentivino l’alfabetizzazione digitale e la specializzazione tecnica, anche attraverso strumenti normativi e fiscali. Il diritto, infine, può contribuire creando un quadro regolatorio chiaro, stabile e favorevole all’innovazione, che valorizzi le competenze e ne favorisca la diffusione. Solo un’azione sinergica tra pubblico e privato potrà garantire che le risorse stanziate si traducano in progetti concreti e sostenibili, capaci di rafforzare la competitività del Paese nel panorama digitale europeo.