Negli ultimi anni, gli operatori di telecomunicazioni europei hanno continuato a lanciare l’allarme: i ricavi sono in forte calo e competere con gli hyperscaler sembra impossibile. Le loro richieste di protezione politica, attraverso meccanismi come un contributo di “fair share” da parte dei giganti digitali o l’allentamento delle regole sulla neutralità della rete, si sono fatte sempre più insistenti.
L’APPROFONDIMENTO
Consolidare o non consolidare: è questo il vero dilemma?
I margini in calo e la frammentazione nazionale spingono verso fusioni e acquisizioni nelle Tlc, ma senza un quadro antitrust e industriale aggiornato il consolidamento rischia di non tradursi in vera competitività globale
docente di Telecomunicazioni,Osservatorio 5G Politecnico di Milano
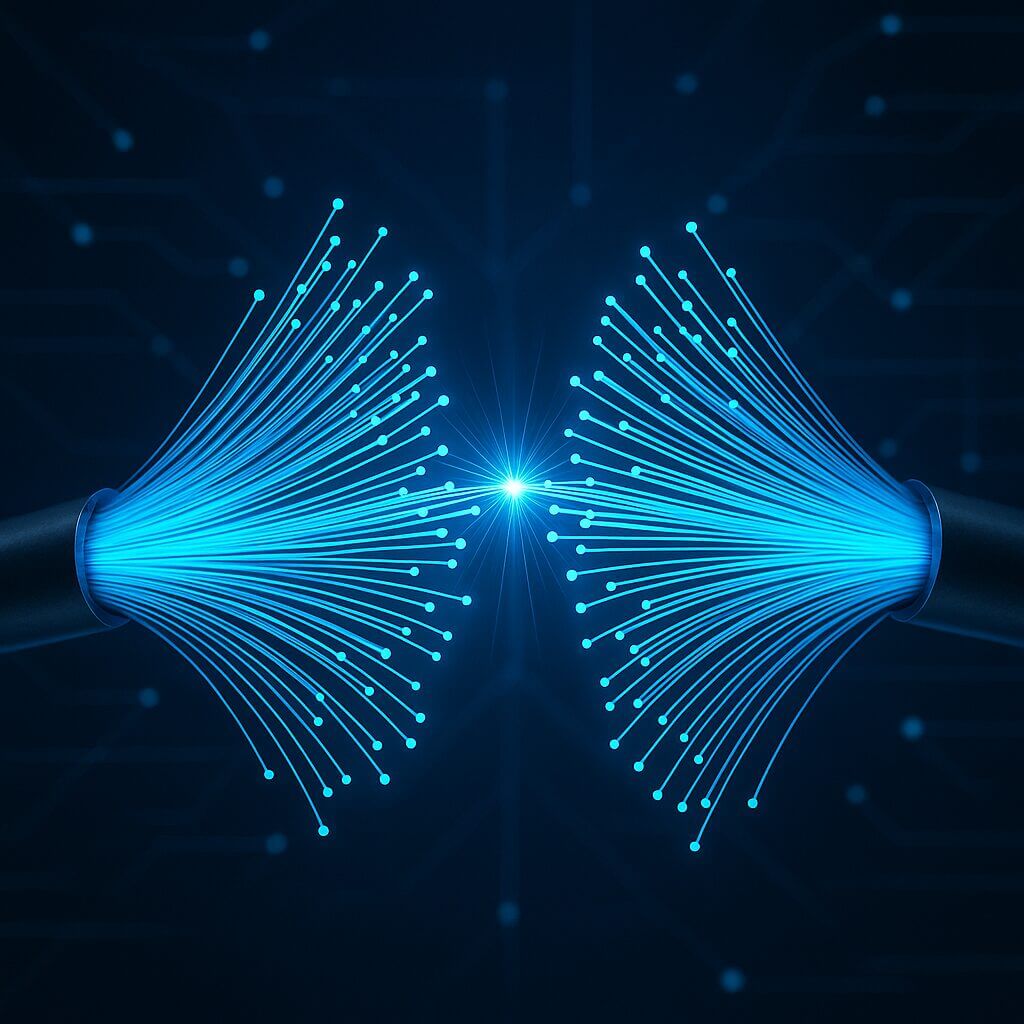
Continua a leggere questo articolo
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business











